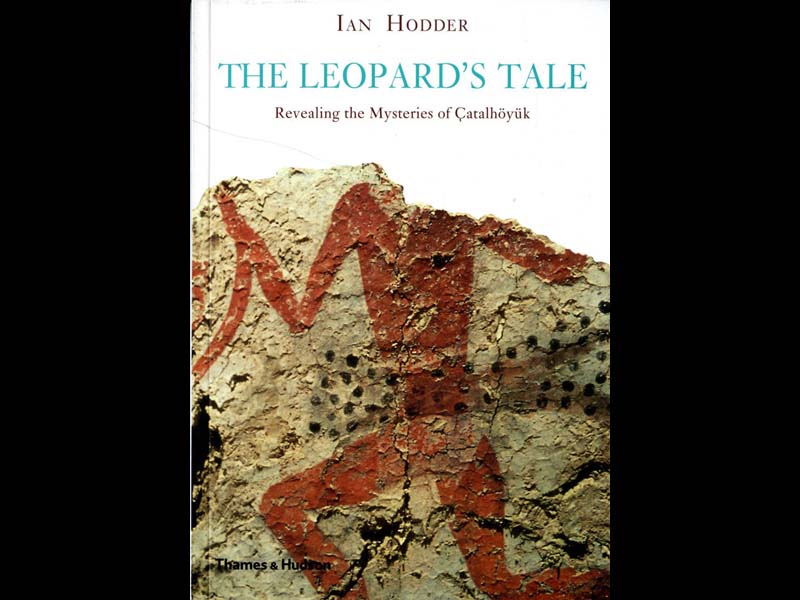di Arianna Carta
Che Marija Gimbutas fosse un genio e che abbia rivoluzionato l’archeologia del Neolitico, è un dato di fatto che si evince chiaramente dalla sua carriera universitaria, pubblicazioni e direzione di scavi internazionali in un’epoca in cui le donne archeologhe dovevano stare chiuse nelle loro stanzette. Poco nota al di fuori degli ambienti accademici, è invece la demonizzazione di cui è stata oggetto, soprattutto nell’ ambito da cui proveniva, quello archeologico. In questo documento, estratto da un mio articolo appena pubblicato, cercheremo di capire i motivi.
Il discorso sulle divinità protostoriche femminili ha radici lontane ed è stato teorizzato in vari ambiti da numerosi studiosi, con una predominanza degli storici delle religioni: Bachofen, Frazer, E.O. James, Graves, Russel, Neumman, Campbell, tra gli altri.
In ambito archeologico, fino alla prima metà del ‘900 ed oltre, a livello internazionale c’era un implicito accordo sul culto della Dea madre in cui le statuette del Paleolitico e Neolitico erano considerate la prova materiale di questa divinità. L’interpretazione più comune era quella che collegava la divinità femminile al culto della fertilità, che si esplicava nell’enfasi data a seni e vulva delle statuette. Questa interpretazione ha raggiunto uno dei suoi apici con le scoperte negli scavi di James Mellaart presso il sito neolitico di Çatalhöyük in Anatolia. Durante gli scavi, sotto gli occhi dell’archeologo si sono presentate decine di bassorilievi raffiguranti donne “nell’atto di partorire”. Tra i tanti reperti trovati, vi è quello che è poi diventato l’emblema del sito archeologico, la famosa statua della donna seduta su un trono con due leopardi.

Secondo Mellaart sul sito sorgeva una città consacrata al culto della Dea madre. Alcuni anni dopo, l’archeologa Marija Gimbutas, non solo ha confermato le sue ipotesi, ma ha condotto uno studio multidisciplinare sulle statuette femminili e i relativi simboli, affermando che nella “vecchia Europa (Old Europe)” durante il Neolitico erano venerate molte Dee (o una singola Grande Dea -Great Goddess- che si presentava in varie forme). Le sue teorie hanno generato forti reazioni accademiche sia pro che contro, soprattutto in ambito archeologico. Per spiegare le motivazioni di queste accese prese di posizione, è necessario esporre le controverse questioni che intersecano il discorso delle divinità femminili in ambito archeologico, la loro relazione con le statuette femminili e il legame con il “potere” delle donne.
Dopo Mellaart un altro archeologo, Ian Hodder, considerato il padre dell’archeologia post- processuale, ha preso la direzione degli scavi di Çatalhöyük e nel corso dei 20 anni di ulteriori scavi ed analisi, si è reso conto che negli edifici del sito non erano solo rappresentate donne ma anche molti animali, specialmente felini e tori/vacche. Forte di questa scoperta, capovolgendo le precedenti interpretazioni, ha pubblicato un saggio dal titolo, The Leopard’s Tale: Revealing the Mysteries of Catalhoyuk (2006), il cui focus è sugli animali invece che sugli aspetti divini del femminile.
Lo stesso archeologo, pur di negare la forte presenza di simbologie femminili, insiste affermando che “possiamo parlare di violenza, sesso e morte nell’immaginario di Çatalhöyük semplicemente in termini di prodezze maschili”, argomentazione che curiosamente ricalca quella elaborata da Peter Ucko (1962), in cui lo studioso lamentava che “le statuette maschili sono ripudiate perché raffigurano le prodezze delle divinità maschili.”
Anche Michael Balter (2016) nel suo saggio The Goddess and the Bull, anch’esso dedicato al conteso sito archeologico, afferma che Gimbutas soffre di “nostalgia per un paradiso perduto egualitario in cui le donne avevano potere anziché venire calpestate.” Testo che, non tanto implicitamente, presuppone che il genere femminile non solo venga costantemente calpestato ed umiliato ma anche che una società dove le donne possano avere un peso ed un ruolo sociale sia inimmaginabile, o meglio, che possa solo appartenere al regno della fantasia.
Nel frattempo, le archeologhe cercavano di farsi valere, dopo decenni di posizione subordinata all’interno dell’accademia, e puntavano l’attenzione sul ruolo delle donne nelle epoche prese in esame. Come ha evidenziato l’archeologa Joan Gero, infatti, ci si aspettava che le donne archeologhe potessero esclusivamente lavorare in luoghi chiusi come laboratori o musei dove venivano catalogati i materiali/reperti avventurosamente trovati dalla loro controparte maschile. A questo proposito Gero conia il termine di “women-at-home-archaeologists” e, in effetti, la direzione di scavi internazionali affidati a Marija Gimbutas, è da considerarsi eccezionale nella sua rarità…
E se si pensa che si tratti di questioni ascrivibili al passato, anche se recente, nel 2020 è stato pubblicato un saggio che ci ricorda come ancora oggi ci sia la necessità di ribadire il ruolo delle donne nella preistoria. La paletnologa francese Marylène Patou-Mathis, direttrice del CNRS (Centro Nazionale di Ricerca Scientifica/National Center for Scientific Research), scrive infatti un saggio dal provocatorio ma significativo titolo: L’homme préhistorique est aussi une femme: Une histoire de l’invisibilité des femmes (tradotto in italiano col titolo: La preistoria è donna. Una storia dell’invisibilità delle donne) che svela e denuncia l’impostazione androcentrica dell’archeologia, dimostrando attraverso vari esempi come le interpretazioni dei reperti preistorici siano ancora incentrate sull’idea che gli uomini siano gli artefici delle principali invenzioni nonché́ i fautori dell’avanzamento tecnologico che ha portato la civiltà, mentre le donne sembrano occupare posizioni secondarie, subordinate e di poco prestigio.

Le denunce contro il sessismo, la misoginia e gli stereotipi di genere portati avanti dalle (archeologhe) femministe, sono numerosi. L’archeologa americana Bettina Arnold, per esempio, ha più volte denunciato l’androcentrismo dell’establishment archeologico, affermando che le interpretazioni sulle donne in posizioni di potere nella preistoria rientrano in un range che va da un “benevolo disinteresse” ad un “attivo sabotaggio” specialmente quando si tratta di sepolture molto ricche [e quindi particolarmente significative a livello di potere].
Gli studi di genere e l’archeologia: “add gender and stir”?
Intanto, un breve chiarimento sui termini sesso e genere: mentre il sesso si riferisce ai genitali con cui nasce una persona, il genere si riferisce all’identità socialmente costruita del maschile e del femminile.
Mentre la corrente femminista archeologica fino agli anni 70-80 è stata interessata principalmente a svelare l’androcentrismo della disciplina assumendo le categorie “donna” e “uomo” senza metterle in discussione, gran parte delle studiose e degli studiosi che hanno aderito alle teorie di genere, assorbite dall’archeologia post-processuale, mettono l’enfasi sulla costruzione culturale delle identità considerate fluide, dai contorni non netti e soprattutto, determinate culturalmente e socialmente. Da un lato assistiamo quindi allo scontro tra accademiche femministe che accusano di essenzialismo l’impostazione di archeologhe come Gimbutas, per esempio, o in generale di tutte le studiose che si occupano dei ruoli socio-economici, status e culti che riguardano le donne nella preistoria, dall’altro abbiamo una serie di archeologi e archeologhe che, aderendo alla interpretazione di genere che si è affermata nel post-processualismo, utilizzano spesso una procedura nota come “add gender and stir”, traducibile come: “aggiungere il genere e mescolare” che descrive la pratica piuttosto comune in ambito archeologico, di utilizzare l’approccio di genere in modo posticcio e privo di un riferimento metodologico adeguato, semplicemente perché risponde ad un trend accademico impossibile da evitare…
Marija Gimbutas: anatomia di un omicidio (accademico)
Nel dibattito archeologico, la figura di Gimbutas è emblematica proprio perché si è ritrovata al centro di un doppio conflitto accademico. Da un lato è stata una delle prime archeologhe donne a condurre importanti scavi, occupando una posizione di grande rilievo in un mondo universitario dominato da figure maschili. Oltre a questo, pur non avendo mai aderito al movimento femminista, si è trovata invischiata all’interno delle dispute tra le archeologhe femministe e quelle dell’archeologia di genere, che le hanno aspramente contestato il suo gender essentialism, (vedi Conkey e Tringham 1995; Eller 2000; Navickaitė 2019) in un momento in cui le teorie femministe e dei Gender Studies sono confluite all’interno del dibattito accademico archeologico postmoderno, come già accennato.
Se per esempio si legge il saggio: A Companion to Gender Archaeology (2012), non solo gli studi di Gimbutas vengono criticati aspramente (si veda il contributo di Goodison e Morris), ma anche quando si tratta esplicitamente di genere e potere nella preistoria, vengono celebrati a più riprese i concetti di “ambiguità, contraddizione, diversità” (Hutson, Hanks e Pyburn) fino ad arrivare alla “preistoria queer” di Benjamin Alberti (2012).
Gimbutas è stata la prima (e rimane una delle poche archeologhe) che, pur non appartenendo al movimento femminista ha tentato (a mio avviso con successo) di rileggere, rianalizzare gran parte della cultura materiale archeologica afferente alla “Vecchia Europa”, soprattutto statuaria e vasellame, ma non solo, per trovare “patterns that connect”, analogie, legami simbolici e culturali…e ciò che ha trovato sono migliaia di archetipi semanticamente collegabili al femminile che lei ha declinato come attributi della Dea.
Un altro grande merito di Marija Gimbutas è stato quello di aver divulgato studi che normalmente appartengono solo agli addetti ai lavori, verso un vasto pubblico anche non accademico, tanto che l’antropologo britannico Joseph Campbell (1989), nella introduzione al saggio The Language of the Goddess paragona il lavoro accademico di Gimbutas alla decifrazione della Stele di Rosetta che ha permesso di capire i geroglifici.
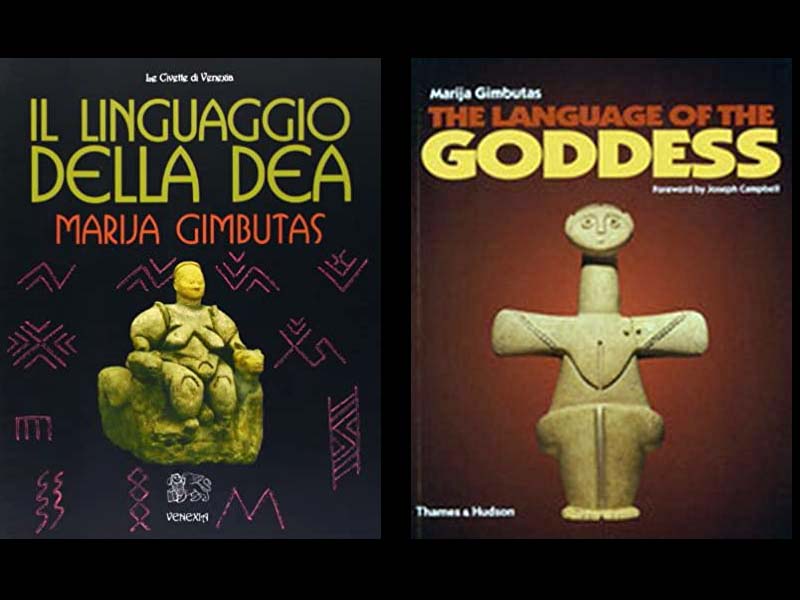
Inoltre, il tentativo di Gimbutas di analizzare di più di 2000 simboli, attribuibili al culto della divinità femminile, rappresenta un unicum in un ambito archeologico che mal accetta collaborazioni con discipline umanistiche, apparentemente teso a non oltrepassare i sicuri limiti del contesto di scavo. Questo è avvenuto anche grazie alle sue conoscenze linguistiche che le hanno permesso l’accesso ai risultati di scavi di tutta l’area dell’Europa centrale che non erano stati mai tradotti e quindi sconosciuti in ambito internazionale. A tal proposito, persino una studiosa a lei avversa, come Cynthia Eller (2000), ammette “le sue straordinarie conoscenze linguistiche” e la sua “conoscenza enciclopedica dei siti archeologici dell’Europa centrale e orientale che le ha permesso di produrre concrete ipotesi su domande di così ampia portata.”
Dall’altro lato, vorrei evidenziare il suo approccio realmente multidisciplinare che si è avvalso delle conoscenze di linguistica, mitologia e folklore, simbolismo, archeologia ed antropologia, frutto anche dei suoi studi di dottorato in archeologia preistorica, storia delle religioni ed etnologia svolto presso l’università di Tubigen nel 1946. La sua carriera accademica, sviluppatasi presso le Università di Harvard e Ucla negli Stati Uniti, include la direzione di scavi internazionali, 20 saggi accademici e più di 200 articoli scientifici tradotti in diverse lingue, molto più di quanto la maggior parte degli archeologi, o degli accademici in generale, possa ambire. Eppure, ancora oggi nominare Gimbutas in ambito archeologico desta forti sospetti e reazioni ostili.
Argomentazioni contro Gimbutas: dalla sindrome da menopausa al trauma politico.
Tralasciando il valore e la portata dei suoi studi di cui tante studiose e studiosi hanno scritto, vorrei ora evidenziare le argomentazioni utilizzate in ambito accademico archeologico per confutare le ipotesi di Gimbutas.
Come accennato precedentemente, in ambito postprocessuale, anche le archeologhe che si definiscono femministe utilizzano argomentazioni decisamente poco accademiche sia nel tono che nei contenuti quando si riferiscono al suo lavoro. Qui di seguito una breve selezione:
Le archeologhe inglesi Goodison e Morris (2013), scrivono che il lavoro di Gimbutas è equiparabile ad una favoletta in cui l’umanità sarebbe precipitata dall’Eden del Neolitico ad un mondo maschilista che avrebbe “rovinato il loro party”! In generale le archeologhe criticano il culto della Dea madre promuovendo a grande ‘distruttore delle teorie sulla Dea’ nientemeno che Ian Hodder!
Secondo le studiose, l’argomento principale che dimostrerebbe la malafede di Gimbutas è il fatto di non aver menzionato nelle sue opere la statuetta degli “amanti di Ain Sakhri”, per paura di smentire le sue teorie. Impressionata dalla portata di quest’affermazione, sono andata a cercare informazioni su questo reperto così importante e controverso da ribaltare le teorie sull’esistenza di divinità femminili. Trattasi di una statuetta in pietra del 9000 A.C. che mostra una coppia probabilmente in fase di amplesso.
In quale modo questo amplesso ribalterebbe le teorie di Gimbutas, mi è difficile capire. La mia perplessità accademica aumenta col procedere dell’articolo in cui vengono citati i disdicevoli comportamenti delle seguaci della Dea a Çatalhöyük che hanno commercializzato l’immagine della Dea attraverso una cannuccia! Mi fermo qui per motivi di decenza (accademica): l’inconsistenza e la malafede delle argomentazioni è piuttosto evidente. Nel primo caso la si accusa di non aver incluso nelle sue opere una statuetta su centinaia analizzate, per paura che avrebbe contraddetto teorie in cui esisterebbero solo ed esclusivamente esempi femminili. In realtà Gimbutas (2005), trattando l’argomento delle “nozze sacre”, analizza per l’appunto la statuetta che, secondo lei, “rappresenta l’unione dell’uomo e della donna.” Sic et simpliciter.
Nel secondo caso si mescolano i piani metodologici con una nonchalance invidiabile: usare come argomentazione accademica un gruppo di donne che producono cannucce con l’immagine di una statua, è quantomeno bizzarro, tanto quanto mettere in primo piano gli animali piuttosto che una donna che siede su un trono, probabile “antenata” di divinità come l’anatolica Cibele spesso raffigurata su un trono trainato da grandi felini…ma evidentemente la comparazione iconografica non viene considerata una metodologia sufficientemente valida per poter essere utilizzata all’interno dell’ambito archeologico.

Sempre in ambito post-processuale, gli archeologi Lynn Meskell e John Chapman cercano di screditare Gimbutas non attraverso un serio dibattito accademico, discussioni su teorie e metodologie archeologiche, bensì sfruttando le loro doti psicologiche e mostrando un notevole expertise in ambito ginecologico.
Lynn Meskell (1995), in un articolo dal provocatorio titolo: “Goddesses, Gimbutas and ‘NewAge’ archaeology”, pur riconoscendole dei meriti accademici, soprattutto per quanto riguarda la direzione degli scavi nell’Europa sud orientale, afferma che la teoria dei guerrieri Kurgan che invadono la pacifica società della Vecchia Europa, derivi dalla traumatica esperienza dell’invasione sovietica della sua terra natia, mentre il collega John Chapman (1998), concordando sui traumi che avrebbero generato nella “debole mente di Gimbutas un immaginario di maschi guerrafondai”, trova nella menopausa la risposta alle teorie sulla Dea madre. Nel suo testo, dopo essersi scusato più volte per essere costretto a trattare “una questione molto delicata per uno studioso di preistoria maschio”, si chiede se il fatto che Gimbutas nelle sue ricerche insista tanto sulla fertilità sia dovuto al fatto che lei, essendo in menopausa, l’aveva persa. John Chapman, professore emerito di archeologia preistorica presso l’Università di Durham.
Accanto al professore si staglia la collega Meskell (1995), autoproclamata femminista, che critica le teorie di Gimbutas, passando dalla generica, “pura fantasia” alle accuse di stampo politico: “sessismo inverso”, “agenda ginocentrica” / “narrative ginocentriche”. Del resto, l’archeologa, considerata una delle più importanti esponenti del post-processualismo, ha fatto parte del gruppo di lavoro di Ian Hodder nel sito di Çatalhöyük, evidentemente appoggiandone le interpretazioni.
In generale, le argomentazioni dei due archeologi, lontane da qualsiasi aderenza a teorie e metodi di qualsivoglia disciplina accademica, si fondano su attacchi che non esito a definire misogini. Certamente una delle critiche più fondate da un punto di vista strettamente archeologico, espressa da Meskell e ripresa da vari studiosi/e, è che Gimbutas abbia elaborato una teoria univoca su statuette che appartengono a contesti archeologici diversi, periodi diversi e zone geografiche molto lontane. Ma se consideriamo quest’analisi in un’ottica più ampia, alzando il naso dal singolo scavo archeologico ed osservando le incredibili analogie tra statuette che effettivamente appartengono a periodi diversi e contesti diversi, allora le teorie di Gimbutas ci appaiono più plausibili. Certamente fallibili, come tutte le ipotesi o teorie che normalmente vengono smentite, rimodulate, discusse ecc. Per il resto, leggendo questi articoli, si ha l’impressione che queste critiche siano fondate su ‘voci di corridoio’ piuttosto che su un’attenta lettura dei testi. Per esempio, a differenza di ciò che scrive Meskell, Gimbutas non parla di “Dea madre” quanto di una Dea che racchiude in sé sia gli aspetti della vita che quelli della morte (vedi Gimbutas 1982), come non parla di matriarcato, che è un’altra delle classiche accuse che le si rivolgono, ma di “società matristica, matrilineare (matristic, matrilinear) (Gimbutas, 1991, 2005, 2008). D’altro canto, se consideriamo seriamente la conclusione dell’articolo di Meskell (1995) in cui si afferma: “l’enfasi su un sesso escludendo l’altro, è non solo dannosa agli studi di genere o femministi, ma minaccia l’integrità interpretativa dell’archeologia”, e invertiamo il genere della sua argomentazione, potremmo chiederci come possiamo affidarci a metodologie ed interpretazioni maschiliste che continuano a caratterizzare una parte della pratica e teoria archeologica. Quale integrità interpretativa possiamo aspettarci da una disciplina che continua ad escludere la sfera femminile dalle sue indagini?
Ai posteri l’ardua sentenza. Per ora mi auspico che studiosi e studiose continuino a leggere i testi di un’ archeologa che ha avuto il coraggio e le capacità di rivoluzionare la preistoria europea attraverso teorie, che se venissero finalmente accettate, cambierebbero in modo radicale una narrazione storica che continua a non riconoscere (o peggio screditare) l’immensa portata simbolica, sociale e culturale di almeno tre millenni in cui le donne avevano un potere riconosciuto e accettato in un’area ampia almeno quanto l’Europa.
Per concludere quindi, chi ha paura della Dea? Ma soprattutto, perché siamo ancora disposti e disposte ad accettare che una mistificazione così palese continui a rappresentare la narrazione ufficiale trasmessa in modo così pervasivo e costante da diventare una verità storica e quindi la base di una identità collettiva che reitera e giustifica un trattamento non paritario, e non riconosce le proprie origini?
Arianna Carta, Dottoranda in Antropologia culturale presso l’Università del Litorale di Capodistria, 2022
Per bibliografia ed articolo completo (in inglese) si rimanda al link: “Who’s Afraid of the Goddess? Leopard’s Tale, Menopausal Syndrome: Terms of Debate within Archaeology”